LIBRI DI TRAVERSO
Vera Gheno GRAMMAMANTI e FEMMINILI SINGOLARI
di Silvia di Fresco
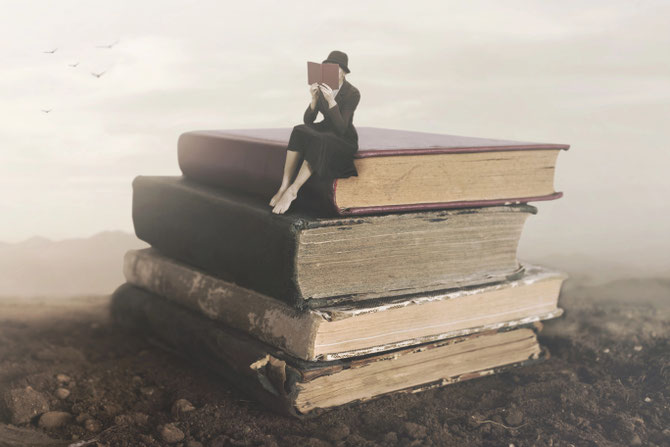
Da un po’ di tempo a questa parte, ogni volta che in classe affronto temi relativi al genere, percepisco un fastidio sempre più elevato. Al contempo so quanto sia importante parlare della cultura patriarcale a studenti che vivono immersi/e in un contesto socio-culturale polarizzato e che rischiano di credere alla fantomatica teoria gender. Senza contare la trap, i twitter deliranti di Trump e Musk e le assurdità pronunciate in merito da insigni esponenti della politica nazionale. Per uscire dall’impasse decido di cercare qualche idea concreta attraverso la lettura di alcuni libri: Grammamanti e Femminili singolari di Vera Gheno.
Il primo è un saggio che mette al centro il linguaggio e ne traccia una breve storia amorosa, soffermandosi in particolare sul potere, assoluto e relativo, delle parole. Di fronte a chi sostiene che non è certo cambiando la lingua che si cambia la società, l’autrice afferma, con Audre Lorde, che in effetti «gli strumenti del padrone non smantelleranno mai la casa del padrone» [1], ma che «la lingua, di per sé, non è lo strumento del padrone, bensì di chiunque; […]Il vero strumento del padrone è l’apparato delle regole»[2]. Ecco dunque la motivazione centrale per non rimanere indifferenti al maschile sovraesteso e praticare la riflessione sulla lingua più che la docenza della grammatica; ed ecco anche spiegati i variopinti attacchi di Galli della Loggia e di Perla alle Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica del Giscel[3]. D’altronde pensare all’italiano come un monolite da difendere è quasi come pensare che il problema della violenza giovanile si possa risolvere con decreti repressivi…
«La lingua è, in un certo senso, il regno delle infinite possibilità, e soprattutto quando è in salute, risponde velocemente e puntualmente alle necessità della comunità che la parla.» [4] Qui però mi sorge un ulteriore dubbio: l’insistere, ad esempio, sul femminile professionale o su un linguaggio amplio è solo una mia esigenza o lo è anche per le mie classi? Dove finisce l’educazione e dove inizia la manipolazione? Forse la risposta è proprio nel titolo, grammamanti, perché si sa, quando si ama poco importa la finalità, ciò che conta sono le emozioni, i sentimenti, la passione. Se in aula riuscirò a far passare tutto questo, allora avrò anche educato alla comprensione, alla libertà di scelta e al rispetto, perché il «rispetto passa dal nominare le cose correttamente» [5] e trova il suo opposto nel grammar nazi[6], ovvero la cieca sottomissione alla presunta tradizione linguistica, tradizione che se considerata inamovibile contribuisce non solo alla morte della lingua (ontologicamente viva e cangiante), ma anche alla morte delle idee (ontologicamente vive e cangianti).
Il giorno in cui ho programmato di spiegare il genere dei nomi entro dunque in classe molto motivata. Tra l’altro il manuale di Serianni in adozione[7] include al suo interno una scheda con la contestualizzazione del suffisso -essa e dei femminili professionali, pertanto mi sento ancora più sicura. Inizio con una domanda:
Qual è il femminile di chirurgo? E di medico?
Varie voci si levano da una parte all’altra: non esiste!!! non c’è!!!
Ma nella vostra vita avete incontrato donne che fanno questo lavoro?
Perplessità, dubbi, insicurezza sui volti.
Quindi? Se qualcosa esiste, deve esistere anche la parola per nominarla, giusto?
Dal fondo Agnese[8], a bassa voce, sussurra: chirurga…medica…
Non appena sorrido e annuisco, si alza un coro quasi unanime: ma suona male!!!
Ci siamo, ecco la vexata quaestio dell’estetica linguistica, osso durissimo da smantellare visto che chiunque pensa che le proprie orecchie siano giudici assoluti. «Chi può ergersi ad arbitro di ridicolaggine o di bellezza? Da un punto di vista linguistico non esiste motivo al mondo per cui, in presenza di donne che svolgano un certo mestiere o una certa funzione, alcuni nomi di mestieri e funzioni abbiano un femminile ed altri no.»[9]
Allora visto che vi suona male come facciamo? Diciamo chirurgo e medico? Mi ha operato il chirurgo Lucia Mondella[10]?
Qui, e cerco di contenere l’autocompiacimento, altri cori: no prof., è scorretto, non concorda!
Ottimo! Quindi? Che si fa?
Silenzio.
Vi piace la parola pneumatico? A me no, mi suona proprio male, eppure se ho forato e devo andare dal meccanico devo usarla, quindi possiamo dire che la vera o presunta bellezza linguistica non ha a che fare con l’utilità e forse è solo una questione di abitudine. Ad esempio… e inizio a spiegare il maschile e il femminile dei nomi mobili. Torneremo sull’argomento a maggio, quando – in Educazione civica- faremo un laboratorio utilizzando come strumento proprio Femminili singolari di Vera Gheno. Poiché in questo testo, oltre ai primi capitoli che contestualizzano il dibattito pubblico sui femminili professionali, sono riportati post e commenti volti a sostenere la scorrettezza o la bruttezza di talune parole declinate al femminile, l’idea è quella di dividere la classe in gruppi e dare loro qualche perla come questa a cui rispondere: «Un ennesimo tentativo di maltrattare la lingua italiana. E perché non dentisto? Anche camionisto non suona male, ieri poi ho chiamato il mio elettricisto e credeva fossi pazzo, e naturalmente voglio vedere GIORNALISTO sul mio amato corriere…».[11] La mia speranza è che, avendo studiato il genere dei nomi, risponderanno spiegando all’ignorante che si crede un sapiente simpatico che esistono nomi identici al femminile e al maschile[12] e che, proprio per questo, gli esempi che annovera a sostegno della propria tesi non hanno senso perché non sono nomi mobili. Insomma, continuiamo a riflettere sulla lingua in modo da imparare anche che, nei dibattiti sui social e non, ciò che vale non è gridare più forte ma la correttezza delle proprie argomentazioni.[13]
Sarà più complesso invece affrontare l’uso del simbolo grafico dell’asterisco (*) o dello schwa (ə). A inizio anno, per comunicare un compito su classroom, ho usato l’asterisco e Tonio[14], in quell’occasione, mi ha chiesto cosa significasse. Ho risposto che era una modalità utile a non far sentire escluso nessun genere, così come l’ uso dello schwa ma, con mio sommo stupore, un punto interrogativo gigantesco si è dipinto sui loro volti. Non sapevano cosa fosse. Dal dibattito tra gli adulti avrei giurato il contrario quindi, ancora una volta, mi sorge il dubbio di poc’anzi: val la pena portare questo tema in una classe in cui non ne hanno alba? Per fortuna che ad aiutarmi nella scelta è intervenuto il MIM il quale, il 21 marzo 2025, ha pubblicato una nota in cui «al fine di assicurare correttezza e chiarezza nelle comunicazioni ufficiali, si raccomanda di attenersi alle regole della lingua italiana che consentono l’utilizzo di soluzioni linguistiche comunque conformi alla tradizione ortografica italiana.» [15] Tradotto: nelle comunicazioni ufficiali delle istituzioni scolastiche non si possono usare né asterischi né schwa. Le argomentazioni addotte per introdurre tale divieto si basano su alcuni pareri espressi dall’Accademia della Crusca come se, al pari dell’Académie Française o della Real Academia Española, essa avesse potere decisionale in merito alle regole linguistiche o al lessico della lingua italiana. «[…]per l’italiano, al momento, non esistono né un ‘vocabolario ufficiale’ né tantomeno una ‘grammatica ufficiale’. […]La Crusca, nella pratica, non ha un ruolo rigidamente prescrittivo; come tutti gli altri enti interessati a questioni di lingua descrive la realtà linguistica piuttosto che prescriverla.»[16]. Utilizzare tali opinioni come base per diramare una nota significa voler far credere che tale atto burocratico non venga emanato per una precisa scelta politica, ma perché il presunto ente ufficiale dell’idioma nazionale ha decretato che è scorretto. Oltre a essere, come abbiamo visto, falso è anche estremamente manipolatorio: il fine qui non è proteggere la presunta purezza dell’italiano, ma evitare che la scuola faccia entrare il mondo nelle sue aule. Infatti, al di là che tali simboli ci piacciano o meno, già solo il fatto che se ne parli significa che qualcosa nella società si sta muovendo e che il famoso maschile sovraesteso non è più sufficiente a rappresentare la complessità in cui viviamo. Ciò non significa che ci si inventa il neutro quando l’italiano non ce l’ha, come sento dire da moltə, ma semplicemente che si stanno sperimentando forme possibili per far sentire chiunque compreso nella lingua e, quindi, nella nostra comunità. Se in una scuola vi fossero ad esempio alunn* trans, che male ci sarebbe ad utilizzare tale simbolo nelle circolari o nei documenti ufficiali? Cosa toglierebbe a chi si sente totalmente a proprio agio col cosiddetto maschile inclusivo? La ragione per affrontare anche questi temi in classe quando si parla di riflessione linguistica è proprio tutta qui, perché non possiamo far passare l’idea che ci sia un modo giusto e unico di essere e di esprimersi, perché non si tratta di teorie gender o di cultura woke, si tratta di persone e di polis, di aprirsi o di chiudersi, di agire sulla norma o di subirla. Per questo, nel mio laboratorio di Educazione civica, darò da analizzare anche la nota n. 1784 del 21 marzo, perché – come abbiamo detto all’inizio - problematizzare gli usi linguistici significa restituire a chiunque la libertà non solo di saper scegliere le parole con cui dire ciò che pensa, ma anche di comprenderne il potere.
«Le parole possono essere come minime dosi di arsenico: ingerite senza saperlo sembrano non avere alcun effetto, ma dopo qualche tempo ecco rivelarsi l’effetto tossico.» [17]
[1] Audre Lorde, Sorella outsider. Scritti politici, Meltemi, MI, 2022 in Vera Gheno, Grammamanti, Einaudi, TO, 2024, p. 97.
[2] Vera Gheno, Ibidem.
[3] Si veda a titolo di esempio, E.Galli della Loggia, «La disfatta della lingua italiana (c’entra anche Tullio De Mauro)», Corriere della sera, 07/02/2017. Consultabile anche qui: https://www.gliscritti.it/blog/entry/4060.
L. Perla, «Grammatica e latino per contrastare l’analfabetismo di ritorno», La Gazzetta del Mezzogiorno, 30/12/24. https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/editoriali/1618183/grammmatica-e-latino-per-contrastare-lanalfabetismo-di-ritorno.html
[4] Vera Gheno, Ivi, p. 73.
[5] Vera Gheno, Ivi, p. 44.
[6] Dal vocabolario online Treccani: Grammar Nazi), s. m. e f. inv. (iron.) Chi ha la fissazione della correttezza linguistica, senza risparmiare agli altri correzioni e osservazioni pedanti. https://www.treccani.it/enciclopedia/grammar-nazi_%2528altro%2529/
[7] L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota, Le parole sono idee - Edizione verde, Bruno Mondadori Scuola, MI, 2020.
[8] Nome di fantasia
[9] Vera Gheno, Femminili singolari, effequ, FI, 2021, p. 92.
[10] Nome di fantasia.
[11] Vera Gheno, Ivi, p. 68.
[12] Nomi di genere comune
[13] «Proviamo a praticare questo modo di fare nelle nostre discussioni: non rispondiamo a tono a una provocazione o a un’offesa, ma rimaniamo sull’argomento, controbattendo con dati, informazioni, link, fonti attendibili, senza cedere all’istinto omicida, se così vogliamo chiamarlo.» Vera Gheno, Ivi, p. 71.
[14] Nome di fantasia.
[16] Vera Gheno, Ivi, p. 76.
[17] Victor Klemperer, LTI, la lingua del Terzo Reich, Giuntina, FI, 2011.
